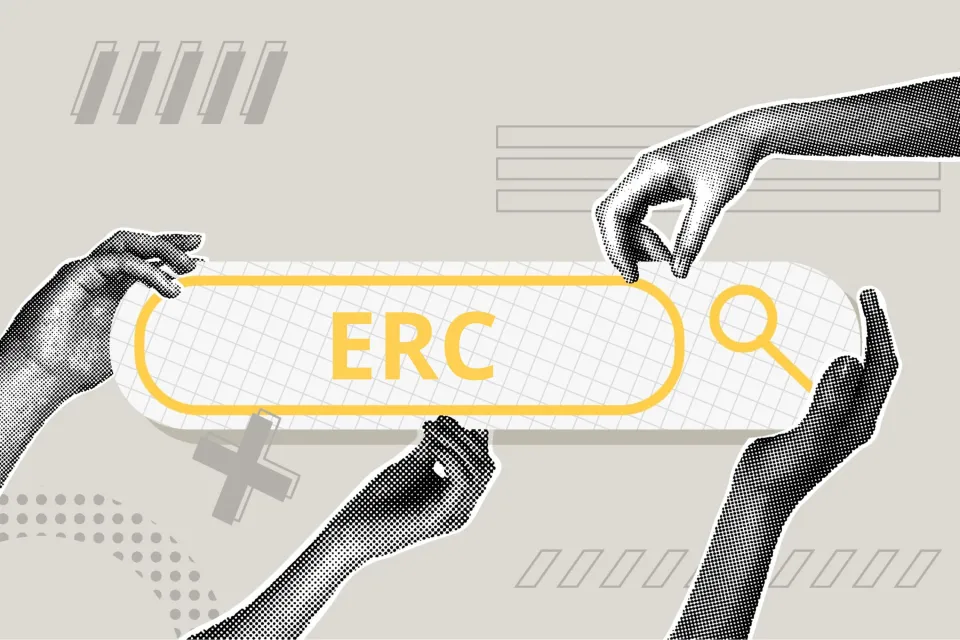
Dove la conoscenza nasce per cambiare le regole
Oltre il caos
Dai pendoli ai pianeti, i modelli matematici hanno spiegato fenomeni complessi. Ma la turbolenza resta un enigma che sfida da secoli scienziati e fisici. MIND prova ad affrontarlo con strumenti nuovi
Di Elia Brué
Ci sono fenomeni naturali che sfidano da secoli la capacità della matematica di incasellarli in regole precise. Il moto di un pendolo, il balletto gravitazionale di due pianeti, persino il caos così come lo descrisse Edward Lorenz: tutti hanno trovato, in modi diversi, una cornice teorica. La turbolenza no. È un enigma che resiste, capace di far vacillare modelli consolidati e di mettere in crisi perfino equazioni considerate “fondamentali”. Non a caso Richard Feynman la definì “il più importante problema irrisolto della fisica classica”.
È in questo territorio instabile e affascinante che si muove MIND – Mathematical Insights into Dynamics of Incompressible Turbulence, progetto finanziato dallo European Research Council, che studia i modelli matematici della turbolenza per comprenderne i meccanismi più profondi.
Esistono sistemi “prevedibili”, detti integrabili, in cui la dinamica può essere risolta con precisione matematica ed espressa da formule. In questi casi, conoscere lo stato iniziale, anche con un piccolo errore, è sufficiente a ricostruire un’approssimazione fedele dell’intera evoluzione. Due esempi classici: il moto di un pendolo ideale, perfettamente descritto con la trigonometria; e la dinamica di due corpi celesti, come Terra e Sole, già compresa da Keplero e Newton.
All’estremo opposto troviamo il caos, studiato a fondo negli ultimi decenni e oggi dotato di un solido framework matematico. Nei sistemi caotici, anche se deterministici, l’evoluzione appare sempre più complessa con il passare del tempo. Un piccolo cambiamento nelle condizioni iniziali viene amplificato, tipicamente con crescita esponenziale. Come scrisse Lorenz: “When the present determines the future but the approximate present does not approximately determine the future.” Uno dei modelli più semplici di questo tipo è quello logistico, che descrive la crescita delle popolazioni.
La turbolenza non è caos: va oltre. Nei modelli che la descrivono la struttura matematica tende a degenerare istantaneamente. Le equazioni possono risultare mal poste, le soluzioni non uniche e irregolari. L’amplificazione dell’errore iniziale può diventare infinita in un attimo. Eppure, in questa apparente assenza di regole, emergono leggi universali osservate in esperimenti e simulazioni, che sfuggono ancora a una comprensione rigorosa.
Gli esempi più noti provengono dalla fluidodinamica, banco di prova della matematica contemporanea. Nel XVIII secolo Leonhard Euler dedusse le equazioni per il moto di un fluido ideale, privo di attrito. Nell’Ottocento Claude-Louis Navier e George Gabriel Stokes introdussero quelle per i fluidi viscosi, che oggi portano i loro nomi e sono fondamentali per meteorologia, ingegneria e scienze ambientali. Eppure, a distanza di secoli, la loro comprensione resta limitata. Per le Navier–Stokes in tre dimensioni non sappiamo nemmeno se esistano sempre soluzioni regolari: uno dei sei celebri Millennium Prize Problems del Clay Mathematics Institute, con un premio da un milione di dollari. Finora, solo la congettura di Poincaré ha trovato una soluzione completa, grazie a Grigori Perelman.
Su queste stesse equazioni, nel 1941 Andrei Kolmogorov propose la teoria fenomenologica K41, che descrive il trasferimento di energia dalle grandi alle piccole scale e alcune leggi statistiche universali. Fenomeni come la dissipazione anomala o la legge zero della turbolenza ne sono pilastri fondanti. A più di ottant’anni di distanza, queste previsioni restano prive di un riscontro matematico rigoroso. Nel 1949 Lars Onsager intuì invece che, in certi regimi, le soluzioni delle equazioni di Euler potessero violare la conservazione dell’energia: una previsione visionaria, confermata solo di recente grazie alla tecnica di convex integration, introdotta da Camillo De Lellis e László Székelyhidi.
Meraviglia pensare che, di fronte a tanta ricchezza di fenomeni e intuizioni, non esista ancora una matematica capace di raccoglierli in una teoria generale.
MIND analizza questi scenari studiando i modelli matematici fondamentali. La turbolenza costringe a considerare regimi in cui le tecniche standard non sono applicabili e i risultati classici non valgono. Per affrontarli è necessario sviluppare strumenti nuovi, con possibili ricadute anche oltre il problema specifico. Allo stesso tempo, l’obiettivo è comprendere meglio le equazioni di Euler e Navier–Stokes, che a secoli dalla loro formulazione continuano a presentare questioni irrisolte.
Capire la turbolenza non significa soltanto risolvere un rebus matematico, ma aprire la strada a progressi concreti in campi che toccano la vita di tutti: dalla meteorologia più affidabile al design aeronautico ed energetico, fino alla protezione dell’ambiente e alla gestione dei flussi nelle città del futuro.






