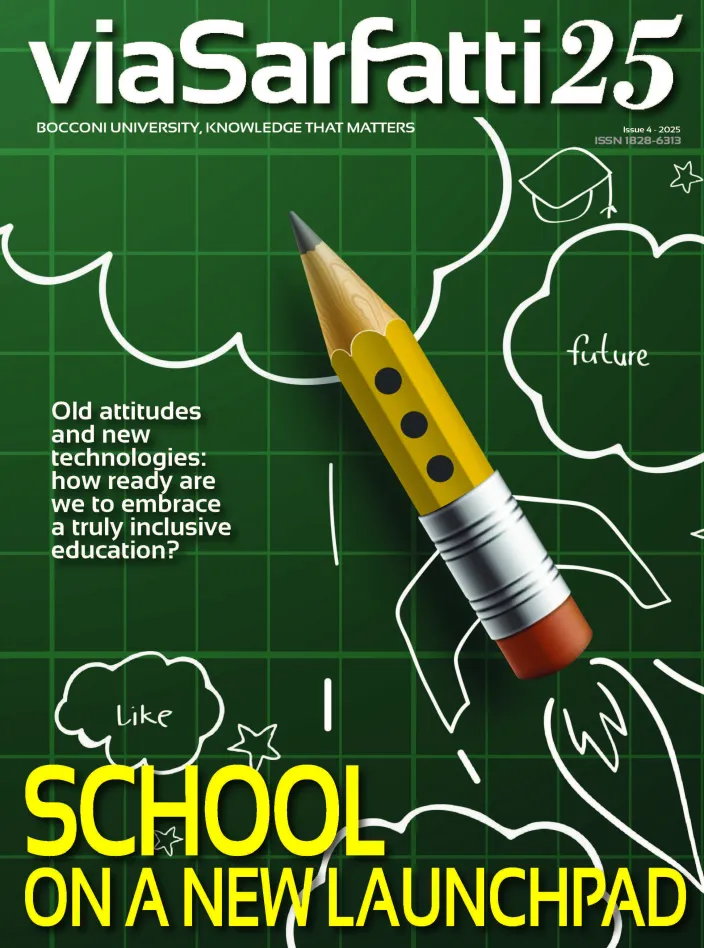
Dentro la scuola: chi include, chi esclude, chi decide
Quando gli insegnanti vedono la solitudine
Un esperimento condotto in 46 scuole italiane dimostra che basta rendere visibile l’isolamento sociale agli insegnanti per ridurre il comportamento antisociale in classe e migliorare l’inclusione. A costi minimi
di Barbara Orlando
Nelle scuole, oltre a imparare, si impara a vivere. Eppure, non tutti i bambini vivono la scuola come un luogo di inclusione. Alcuni sono invisibili agli occhi dei pari, esclusi dai giochi e ignorati dai gruppi. Ma se la solitudine di un bambino diventasse improvvisamente evidente agli occhi degli insegnanti, le cose potrebbero cambiare? È esattamente quello che hanno verificato Sule Alan (Cornell University), Michela Carlana (Università Bocconi) e Marinella Leone (Università di Pavia) in uno studio sperimentale intitolato Inclusive Teaching: Spotting Social Isolation in the Classroom (forthcoming su AEJ: Policy)
Una mappa per spezzare l’invisibilità
Nel corso dell’anno scolastico 2022/2023, le ricercatrici hanno coinvolto 46 scuole primarie pubbliche in Lombardia, Piemonte e Lazio. Ai docenti di metà delle scuole è stato consegnato un semplice strumento: una mappa della rete di amicizie della propria classe, costruita partendo dalle indicazioni dei bambini stessi, accompagnata da dati e informazioni scientifiche sui rischi dell’esclusione sociale, in particolare per studenti con background migratorio o status socioeconomico più basso. “Abbiamo mostrato agli insegnanti che la loro percezione del livello di isolamento tra gli alunni era ampiamente sottostimata rispetto ai dati reali”, racconta Michela Carlana, direttrice del LEAP Bocconi “Molti erano sorpresi nel vedere che uno o più bambini nella loro classe non venivano nominati come amico da nessun compagno. Non era cattiveria, era cecità sociale. E noi abbiamo cercato di curarla”.
Meno solitudine, meno sabotaggi
Dopo sei mesi, i ricercatori hanno rilevato effetti tangibili: la probabilità che un bambino non avesse alcun amico in classe si è ridotta del 50% rispetto al gruppo di controllo. Gli alunni nelle classi trattate hanno ricevuto più nomination come “migliori amici”, segno di una maggiore inclusione. Ma c’è di più. Gli studenti coinvolti nel trattamento erano anche meno inclini a comportamenti antisociali, misurati tramite un gioco sperimentale in cui potevano “sabotare” anonimamente un compagno per ottenere un vantaggio materiale. Nelle classi trattate, la propensione al sabotaggio è scesa dell’11%. Nessun effetto, invece, su comportamenti prosociali come la cooperazione o la donazione.
Più equità in aula, a costi minimi
Per quantificare gli effetti collettivi, il team di ricerca ha simulato i risultati aggregati della “classe come comunità”: quanto rendimento si perde per colpa di atti antisociali? Nei gruppi trattati, i ricercatori hanno registrato un aumento del payoff medio (cioè del “benessere economico” simulato) e una significativa riduzione della diseguaglianza interna, misurata tramite l’indice di Gini. In altre parole, meno sabotaggi equivalgono a più benessere per tutti. Il costo dell’intervento? Solo 21 dollari per studente. “Il bello è che non serve un grande budget: bastano dati, consapevolezza e qualche suggerimento pratico”, spiega Carlana. “Gli insegnanti hanno risposto attivamente: molti hanno cominciato a formare gruppi misti durante le attività, rompendo la dinamica per cui i più bravi o popolari si aggregano tra loro, lasciando fuori i più fragili”.
Una scuola più giusta (e possibile)
Il merito dello studio sta nell’aver mostrato che l’inclusione sociale in classe non è un sottoprodotto accidentale del “fare bene scuola”, ma una pratica che si può insegnare, monitorare e correggere. Rendere visibile ciò che è invisibile – come l’isolamento di un bambino – è il primo passo per costruire comunità educative più giuste. E forse anche per formare cittadini migliori.





