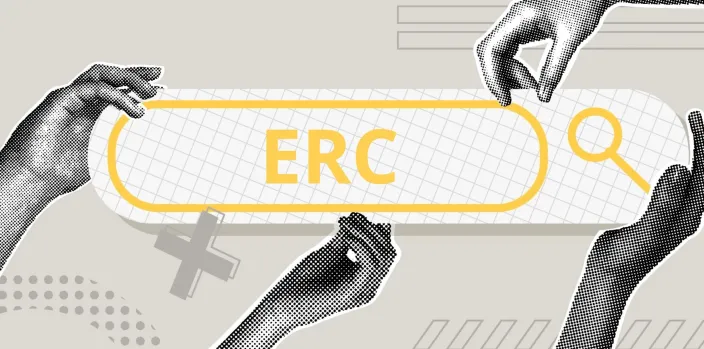Lo Stato che funziona
Firmare un contratto sociale tra cittadini e istituzioni non è mai stato un gesto semplice. Perché gli Stati funzionino davvero – perché sappiano raccogliere risorse, garantire servizi, offrire opportunità – servono tre condizioni: una domanda di presenza pubblica da parte della società, un apparato amministrativo capace di rispondere a quella domanda, e infine istituzioni che operino nell’interesse generale, non corrotte da legami privati. Oggi queste parole possono sembrare scontate, ma basta guardare alla storia per accorgersi di quanto fragile e complesso sia stato il processo di costruzione della capacità statale.
Ed è proprio qui che la ricerca diventa attuale. Comprendere come e perché alcuni Stati siano riusciti a rafforzarsi mentre altri restano deboli non è solo un esercizio di storia economica: è una chiave per leggere il presente. Nel mondo contemporaneo la capacità statale continua a fare la differenza. La vediamo nel modo in cui i governi affrontano crisi economiche e sanitarie, come nel caso della pandemia, quando la tenuta o la fragilità delle istituzioni ha inciso sulla vita quotidiana di milioni di persone. La ritroviamo nelle politiche migratorie, dove la capacità di un Paese di gestire arrivi e integrazione spesso segna la differenza tra inclusione e tensioni sociali. E ancora, la vediamo nei mercati globali, dove i governi sono chiamati a regolamentare giganti tecnologici e nuove frontiere economiche, spesso più veloci dei sistemi normativi. Le sfide che affrontiamo oggi non sono poi così diverse da quelle che comunità e nazioni si trovarono davanti due secoli fa: come garantire servizi pubblici essenziali, come bilanciare interessi privati e bene collettivo, come costruire istituzioni capaci e credibili. Studiare il passato, dunque, significa dotarci di strumenti migliori per interpretare e affrontare il presente.
Con il progetto STATE-DEV, sostenuto da un ERC Starting Grant, ho deciso di affrontare proprio questo nodo: capire come nascono e come si sviluppano Stati in grado di promuovere sviluppo economico e sociale. Per farlo, guardo indietro a due laboratori storici cruciali: l’Italia post-unitaria e gli Stati Uniti della seconda metà dell’Ottocento e della prima metà del Novecento. Due contesti diversissimi, ma accomunati da una rapida crescita del ruolo dello Stato, in cui si può osservare come si siano formate – o come siano mancate – le condizioni per un rafforzamento delle istituzioni.
Le domande sono semplici da formulare, ma difficili da risolvere. Da cosa nasce la richiesta di più Stato? Il progresso tecnologico e le migrazioni possono aver spinto comunità intere a chiedere più scuole, più infrastrutture, più servizi pubblici? In Italia, invece, quale ruolo hanno avuto i prefetti – quei funzionari che incarnavano la presenza dello Stato nei territori – nel plasmare la capacità amministrativa e, con essa, lo sviluppo economico? E ancora: cosa succede quando i confini tra pubblico e privato si fanno porosi, quando funzionari passano nelle imprese e manager privati approdano in burocrazia? È una circolazione virtuosa di competenze, o un canale che alimenta favoritismi e corruzione?
Il cuore di STATE-DEV sta nel tentativo di rispondere a queste domande intrecciando approcci diversi. Non basta la teoria: servono dati, archivi, prove empiriche. Raccoglieremo e digitalizzeremo materiali finora poco esplorati, dai bilanci dei comuni italiani alle cronache dei giornali locali americani dell’Ottocento, dalle carriere dei prefetti ai registri delle imprese statunitensi. Grazie a tecnologie nuove, come i modelli linguistici applicati a queste fonti storiche costruiremo dataset che resteranno patrimonio comune per la comunità scientifica e che potranno essere usati da economisti, storici e politologi per porre nuove domande e verificare nuove ipotesi.
In questo modo, lo sguardo al passato non è mai puro esercizio erudito. Al contrario, diventa un laboratorio per capire meglio come reagiscono le istituzioni di fronte a sfide improvvise, come si rafforzano o come falliscono. È guardando agli effetti delle migrazioni di massa negli Stati Uniti dell’Ottocento che possiamo trovare parallelismi con i flussi migratori che oggi attraversano l’Africa e l’Europa. È analizzando la figura del prefetto italiano che possiamo chiederci quanto conti, ancora oggi, la qualità della leadership burocratica nei processi di crescita. È studiando i meccanismi della “revolving door” tra pubblico e privato che possiamo ragionare su come regolamentare fenomeni che riguardano anche le istituzioni europee e nazionali contemporanee.
Con STATE-DEV non promettiamo risposte definitive, ma nuove lenti per leggere un tema cruciale: che cosa rende uno Stato capace? E, soprattutto, che cosa possiamo imparare da chi, in passato, ci è riuscito? La posta in gioco non riguarda soltanto gli storici, ma tutti noi. Perché la qualità dello Stato in cui viviamo continua a determinare, in larga misura, le possibilità di crescita economica, la coesione sociale e la solidità della democrazia.