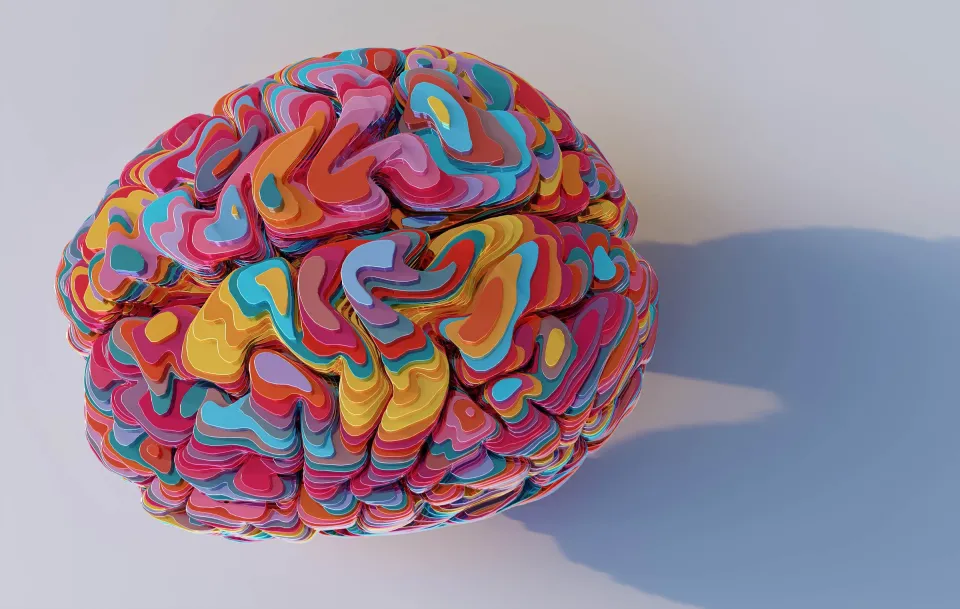
Dentro la mente che decide
L’illusione della scelta semplice
Non falliamo per mancanza di informazioni, ma perché ci concentriamo su quelle sbagliate: la vera sfida non è decidere, ma imparare a dirigere l’attenzione
di Nicola Gennaioli
Sono seduto con il mio tablet, indeciso tra due paia di scarpe da corsa. Una scelta apparentemente semplice, ma ogni modello offre un ventaglio di caratteristiche: peso, resistenza, supporto, prezzo, marca, stile, perfino l’approvazione di atleti famosi. Una punta sul “design ultraleggero”, l’altra su “massimo assorbimento degli urti” e “materiali sostenibili”. Mentre valuto, il telefono vibra: un messaggio, un avviso di sconto, la pubblicità di un nuovo fitness tracker. In un attimo, la decisione si complica. Quello che conta davvero rischia di sparire in una giungla di stimoli. Oggi l’attenzione è il bene più scarso. In teoria, dovremmo concentrarci solo sugli attributi essenziali – nel mio caso le scarpe – ignorando il resto. Ma la realtà è diversa. Numerosi studi di psicologia cognitiva ed economia comportamentale mostrano come la nostra attenzione venga catturata da ciò che è più saliente, non necessariamente più rilevante. Così, una notifica WhatsApp o uno slogan pubblicitario finiscono per orientare le scelte più della qualità o del prezzo.
Complessità: una sfida cognitiva
La complessità che affrontiamo non dipende tanto dal numero di opzioni, quanto dalla quantità di caratteristiche – spesso irrilevanti – che la mente deve gestire. Non sappiamo filtrare perfettamente. Le informazioni salienti ma secondarie oscurano quelle fondamentali; la memoria imperfetta peggiora le cose. Ne derivano due distorsioni: l’eccessiva complicazione e l’eccessiva semplificazione.
Quando il semplice diventa complicato
Decisioni facili diventano difficili perché attributi irrilevanti catturano la nostra attenzione. Un esempio: farmaco di marca contro generico. A parità di principio attivo ed efficacia, il prezzo dovrebbe essere l’unico criterio. Eppure molti scelgono il marchio, come mostrano Dube, Gentzkow e Shapiro (QJE, 2018): anche consumatori informati continuano a pagare di più per il brand. Qui la pubblicità crea valore percepito e complica ciò che dovrebbe essere semplice. Accade anche in finanza. Invece di preferire portafogli semplici e diversificati, molti investitori inseguono etichette come “alta crescita” o “dividendi sicuri”, attratti da slogan e classifiche. Il risultato è un portafoglio complesso, spesso peggiore di quello costruito con poche regole di base.
Quando si semplifica troppo
L’altro rischio è opposto: semplificare troppo. Travolti dagli stimoli, ci fissiamo su uno o due attributi e ignoriamo il resto. È il caso della scelta dei piani sanitari: premi e franchigie sono messi in evidenza, mentre l’uso effettivo della polizza, decisivo per valutare i costi, passa in secondo piano. Loewenstein et al. (QJE, 2015) mostrano che questo porta spesso a scegliere opzioni dominate, cioè peggiori sotto ogni profilo. Lo stesso vale per i fondi comuni: gli investitori guardano ai rendimenti recenti, ben pubblicizzati, e trascurano commissioni e rischi, più rilevanti per i risultati a lungo termine.
La natura della complessità
La lezione è che la complessità non è solo una proprietà dell’ambiente, ma nasce dal modo in cui la mente seleziona, ricorda e associa stimoli. Non falliamo perché incapaci di elaborare abbastanza dati, ma perché scegliamo di concentrarci sulle caratteristiche sbagliate. Questa dinamica mette in crisi i meccanismi classici della concorrenza. Primo: l’attenzione selettiva crea potere di mercato. Alcuni prodotti dominano non per qualità intrinseca, ma perché catturano meglio la nostra attenzione. Secondo: la competizione si gioca solo sugli attributi salienti, lasciando fuori quelli realmente importanti. Nemmeno la fornitura di informazioni o i nudges risolvono il problema: spesso vengono ignorati, o finiscono per influenzare chi non ne ha bisogno, peggiorando le decisioni. La vera domanda è allora: quali protocolli di scelta e di informazione funzionano in un mondo saturo di stimoli? Non abbiamo ancora la risposta. Ma una certezza c’è: non la troveremo finché continueremo a pensare che decidere sia solo questione di calcolo. È tempo di prendere sul serio la cognizione.



