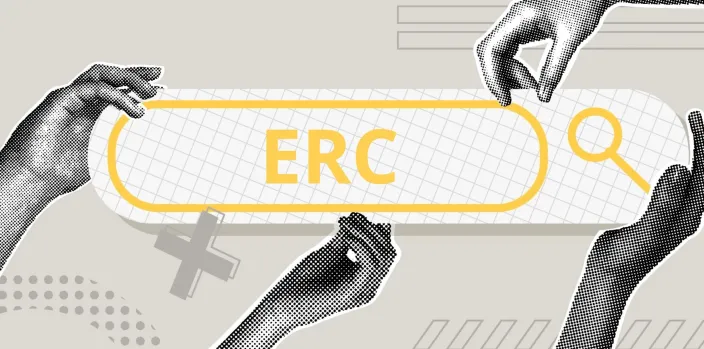Bilanciare profitti e comunità
Negli ultimi due decenni, il mondo ha assistito a un’esplosione di impegni in materia di sostenibilità da parte delle imprese. Nel 2000 nessun Paese aveva leggi sulla sostenibilità aziendale; oggi, più di settanta sì. Dai piani d’azione per il clima ai report di responsabilità sociale, le aziende promettono sempre più spesso di “fare bene facendo del bene”. Eppure, dietro le brochure patinate e gli obiettivi ambiziosi, resta una domanda: le scelte etiche delle imprese portano davvero benefici alla società o sono semplicemente strategie per attrarre clienti e investitori?
Questa domanda è al centro di BALANCE, un progetto di ricerca guidato da me e recentemente premiato con uno Starting Grant dello European Research Council (ERC). Mentre la letteratura si limita perlopiù a misurare ciò che le imprese fanno, BALANCE va oltre e si chiede: qual è l’impatto reale delle imprese sulla società e come, a sua volta, la società influenza le imprese? Quando le aziende interiorizzano le preoccupazioni degli stakeholder, i loro obiettivi si estendono oltre la massimizzazione del profitto. In questi contesti, il compito cruciale è ricostruire il circuito di retroazione tra imprese e società, per capire quando produce benefici e quando invece genera distorsioni.
La novità della prima linea di ricerca sta nel superare la semplice catalogazione delle azioni prosociali, studiandone invece le conseguenze di lungo periodo per persone e territori. Ciò implica affrontare due sfide: distinguere la responsabilità sociale autentica dal greenwashing e identificare gli stakeholder chiave influenzati dai comportamenti prosociali delle imprese. BALANCE affronta la questione partendo da un episodio storico unico: l’enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII (1891), che incoraggiò i cattolici a creare banche cooperative. Queste istituzioni offrirono credito a basso costo agli imprenditori locali e, secondo le prime evidenze, ebbero un ruolo cruciale nella nascita dei distretti industriali italiani. Ciò suggerisce che le azioni prosociali delle imprese possano avere effetti profondi e duraturi, capaci di orientare la crescita economica locale per generazioni. Un ulteriore contributo del progetto sarà la digitalizzazione e messa a disposizione pubblica di decine di migliaia di bilanci storici di società italiane, creando una risorsa preziosa per la ricerca futura.
La seconda parte del progetto guarda al presente e si chiede se la competizione rafforzi o indebolisca l’etica aziendale. Le banche etiche servono spesso clienti più rischiosi, esclusi dalla finanza tradizionale, eppure attraggono depositanti insolitamente fedeli. BALANCE indaga se queste banche prosperino solo perché la loro immagine consente di attrarre clienti meno sensibili ai tassi d’interesse — riducendo l’etica a semplice greenwashing — o perché contribuiscono attivamente accettando margini più bassi per sostenere determinati prenditori. La distinzione è cruciale per i regolatori, che stanno valutando se concedere a queste banche requisiti di liquidità più leggeri, con implicazioni dirette sull’accesso al credito e sul rischio di “desertificazione finanziaria” nelle aree meno servite.
Un’altra linea di ricerca analizza come stakeholder dispersi possano coordinare il proprio impatto. Le università, ad esempio, creano associazioni studentesche che permettono di organizzarsi e farsi ascoltare. Il problema del coordinamento è particolarmente forte per gli azionisti: sebbene i piccoli investitori controllino collettivamente ampie porzioni dei mercati finanziari, spesso restano passivi, incerti sul fatto che altri condividano le loro preoccupazioni. BALANCE affronta il tema studiando il caso dell’ONG olandese Follow This, che ha mobilitato gli azionisti “verdi” di minoranza di Shell. L’esempio mostra come coalizioni dal basso possano influenzare anche le multinazionali più grandi e come, una volta che gli azionisti scoprono di avere simili alleati, estendano le proprie richieste a tutte le aziende nei loro portafogli, diffondendo il cambiamento da una società a molte. Le implicazioni di policy sono significative: una possibile innovazione sarebbe permettere agli azionisti di coordinare i voti per gruppi di preferenza — ad esempio su temi ambientali o standard lavorativi — così da rendere più efficace l’azione delle minoranze.
La parte finale del progetto si concentra sulle catene globali del valore, dove le certificazioni di sostenibilità sono diventate uno strumento centrale per rassicurare i consumatori. Nell’industria della cellulosa e della carta in Uruguay, le piantagioni di alberi a crescita rapida rispettano gli standard di certificazione, ma creano i cosiddetti “deserti verdi”, danneggiando biodiversità e agricoltura locale. Analizzando come le imprese reagiscono alle regole di certificazione, BALANCE mostra come le politiche di trasparenza possano produrre effetti indesiderati, un tema di particolare urgenza mentre l’Unione Europea riconsidera le proprie normative sulle catene di fornitura.
Perché conta adesso
Queste domande risuonano fortemente nel dibattito attuale. A Bruxelles si discutono riforme sulla rendicontazione di sostenibilità. Nei centri finanziari, banche centrali e regolatori si confrontano su come trattare gli istituti che rivendicano una missione sociale. Nei mercati globali, l’attivismo degli azionisti mette alla prova l’equilibrio tra finanza, responsabilità sociale e ambientale. In questo contesto, BALANCE fornisce nuove evidenze su come le strategie aziendali si ripercuotano sulla società — talvolta in modo controintuitivo. I risultati sono destinati a orientare non solo la ricerca accademica, ma anche le scelte di policymaker, investitori e cittadini che cercano di distinguere tra responsabilità autentica e greenwashing.
Verso un nuovo contratto d’impresa
Le imprese non sono solo motori di profitto: sono attori sociali che plasmano comunità, mercati ed ecosistemi. I loro interessi e gli obiettivi della società non coincidono sempre. Identificando le frizioni — che siano concorrenza, asimmetrie informative o sistemi di certificazione difettosi — BALANCE punta a disegnare politiche migliori per avvicinare le strategie aziendali al bene comune.
I progressi in materia di sostenibilità sono spesso lenti, soprattutto negli ambiti sociali e di governance, perché questi valori sono difficili da misurare. Spostando l’attenzione dalla misurazione ai meccanismi, BALANCE mira a ripensare il rapporto tra imprese e società — non come avversari, ma come partner nella costruzione di un futuro più sostenibile.