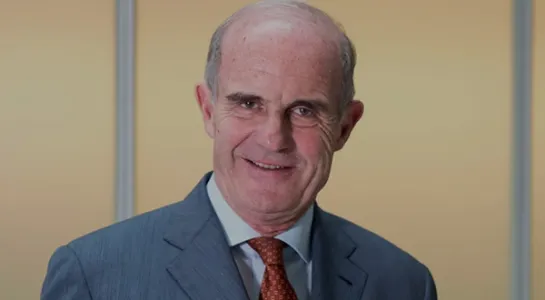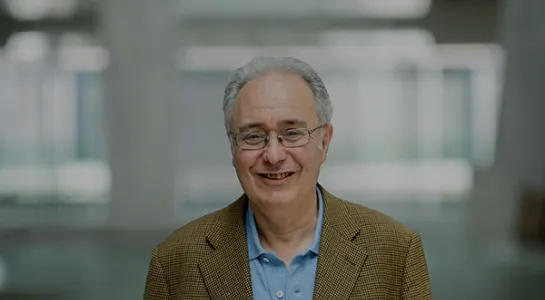Perché i pessimisti vincono sempre
Nel mondo della statistica, uno shock è una cosa nobile. Entra in un'equazione con un'aria di neutralità, tendendo a ritornare alla media come se fosse un cittadino modello. Gli shock, nella loro forma più pura, sono deviazioni imprevedibili con una media attesa pari a zero, né intrinsecamente buoni, né cattivi. Sono, semplicemente, l'equivalente statistico delle piccole sorprese della vita.
Eppure, quando entriamo nel regno della finanza, la storia prende una piega più cupa. Qui, "shock" è un eufemismo per catastrofe. Recessioni economiche, crisi finanziarie: questi sono gli shock che fanno notizia, affondano i mercati e immortalano gli economisti che li prevedono. Ma dove sono gli economisti che prevedono con successo gli shock positivi? Perché nessuno diventa famoso per aver previsto un improvviso boom economico?
Come vedremo, questa asimmetria nella percezione non è casuale. È profondamente radicata nella psicologia umana, sostenuta dal principio dell'avversione alla perdita di Kahneman e Tversky, e ulteriormente amplificata dagli incentivi professionali nel campo dell'economia. Esploreremo perché il mondo della finanza è truccato a favore dei pessimisti e perché, paradossalmente, finiscono spesso per avere "ragione" anche quando si sbagliano.
L'innocenza statistica degli shock
Dal punto di vista statistico, uno shock economico è un cambiamento inatteso in una variabile economica. La parola chiave qui è "inatteso". Che si tratti di un cambiamento politico, di un'improvvisa variazione del sentimento dei consumatori o di una fluttuazione del prezzo del petrolio, la caratteristica distintiva di uno shock è che devia da ciò che era previsto. E, soprattutto, queste deviazioni non hanno un bias sistematico: nel tempo, tendono a una media di zero.
Per ogni recessione economica, c'è un corrispondente boom economico. Per ogni crisi finanziaria, c'è una ripresa inaspettata. Tuttavia, nel discorso pubblico, gli shock positivi raramente fanno notizia. Immaginate un economista che appare in televisione per dire: "L'economia probabilmente supererà le aspettative a causa di fattori imprevisti". Non è esattamente una dichiarazione entusiasmante. Al contrario, gli shock negativi portano con sé dramma, urgenza e, soprattutto, un pubblico desideroso di ascoltare.
Kahneman, Tversky e la tirannia dell'avversione alla perdita
Daniel Kahneman e Amos Tversky, nel loro lavoro fondamentale sulla teoria delle prospettive, hanno introdotto il concetto di avversione alla perdita: l'idea che le perdite pesino psicologicamente più dei guadagni. In altre parole, le persone percepiscono il dolore di perdere 100 dollari molto più intensamente del piacere di guadagnarne altrettanti. Questa asimmetria influenza le decisioni in tutti i campi, inclusi economia e finanza.
A causa dell'avversione alla perdita, investitori, politici e opinione pubblica sono più sensibili agli shock negativi rispetto a quelli positivi. Se una banca centrale alza improvvisamente i tassi di interesse provocando un calo del mercato, viene percepito come un evento significativo, degno di analisi e dibattiti infiniti. Ma se un'innovazione tecnologica porta a una crescita inaspettata, viene spesso liquidata come "il normale funzionamento del mercato".
Questa asimmetria crea un bias strutturale nel discorso economico: la paura vende. Gli investitori vogliono proteggersi dalle perdite, i politici vogliono evitare colpe, e i giornalisti vogliono attirare lettori. Il risultato? Un'enfasi collettiva sugli shock negativi e una quasi totale mancanza di attenzione per quelli positivi.
Il dilemma del profeta di sventura: Come avere sempre ragione prevedendo crisi
Ecco quindi emergere il pessimista professionista, l'economista del "giorno del giudizio" che costruisce la propria carriera prevedendo crisi economiche. Nessuno incarna meglio questo archetipo di Nouriel Roubini, famoso per aver previsto la crisi finanziaria del 2008. Un economista brillante, senza dubbio, ma anche un caso emblematico degli incentivi perversi che premiano il pessimismo persistente.
Come dice la battuta, Roubini ha previsto venti degli ultimi tre shock economici. E non è il solo. Molti economisti hanno costruito reputazioni (e carriere di consulenza molto redditizie) prevedendo disastri. Il motivo è semplice: se un economista prevede uno shock negativo e si sbaglia, viene dimenticato. Se ha ragione, viene acclamato come un visionario.
Al contrario, un economista che prevede shock positivi ha un destino molto diverso. Se si sbaglia, viene ridicolizzato come un ingenuo. Se ha ragione, le buone notizie vengono attribuite alla fortuna, alle politiche adottate o alla resilienza del mercato, non alla sua capacità previsionale.
Perché gli economisti preferiscono prevedere disastri
Media, mercati finanziari e politici sono tutti incentivati a prestare maggiore attenzione alle previsioni negative. Consideriamo i seguenti fattori:
- Sensazionalismo mediatico: "Previsto crollo del mercato azionario" è un titolo molto più accattivante di "La crescita del mercato potrebbe superare le aspettative". Le cattive notizie vendono e chi le porta riceve più attenzione mediatica.
- Gestione del rischio professionale: Un economista che prevede una recessione e si sbaglia affronta poche conseguenze. Chi prevede prosperità e si sbaglia rischia il discredito permanente.
- Psicologia umana: Investitori e politici sono più avversi al rischio che propensi al rischio. Vogliono prepararsi al peggio, rendendoli più ricettivi alle previsioni negative.
- Bias storico: La maggior parte delle teorie economiche principali (keynesianesimo, marxismo, persino l'economia austriaca) sono state sviluppate in risposta a crisi, rendendo il discorso economico intrinsecamente orientato alle crisi.
Un appello all'equilibrio statistico
Gli shock economici, nella loro essenza, sono simmetrici. Possono essere positivi o negativi, e il loro valore atteso a lungo termine è pari a zero. Tuttavia, a causa dell'avversione alla perdita, degli incentivi mediatici e delle dinamiche professionali, l'economia ha sviluppato un bias intrinseco verso la previsione e l'attenzione sugli shock negativi.
Questo non è solo un problema accademico: ha conseguenze reali. Un pessimismo persistente può portare a un'eccessiva avversione al rischio, a occasioni di investimento mancate e a un senso generale di pessimismo economico che si autoalimenta. Forse è giunto il momento che gli economisti rivendichino la neutralità degli shock, riconoscendo che le sorprese possono essere piacevoli tanto quanto dolorose.
E chissà, forse un giorno vedremo un economista diventare famoso per aver previsto un boom inaspettato. Ma fino ad allora, i profeti di sventura continueranno a vincere, anche quando si sbagliano.