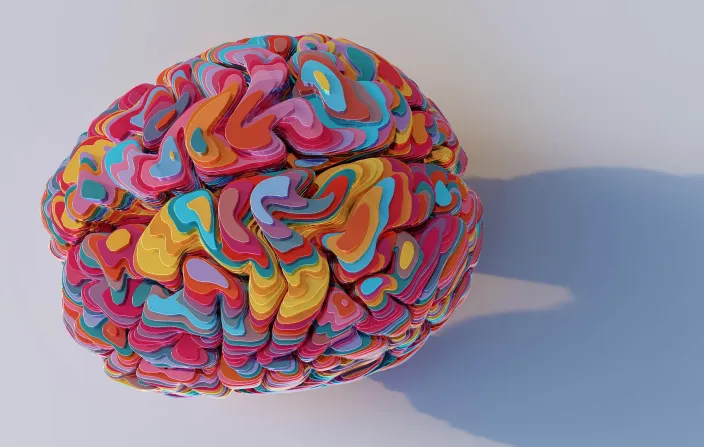Quando i modelli sbagliano
Chi decide – in economia, in politica, in finanza – lo fa sempre sotto incertezza. Ma c’è incertezza e incertezza. Una cosa è non sapere come andrà l’inflazione nei prossimi mesi, altra cosa è non sapere se i modelli con cui stiamo cercando di prevederla abbiano senso.
Prendiamo un banchiere centrale che deve calibrare i tassi d’interesse: userà modelli macroeconomici per stimare gli effetti delle sue decisioni. Ma quei modelli – con tutte le loro equazioni, ipotesi e scenari – sono versioni semplificate e parziali della realtà. Possono essere “utili”, ma sono inevitabilmente sbagliati. O ancora: un governo deve decidere se e come tassare le emissioni di CO₂. Si affida a scenari climatici, costruiti da comunità scientifiche diverse, con modelli diversi. Ma chi può dire se quei modelli colgano davvero le dinamiche più rilevanti? Eppure, si decide. Sempre
Ma cosa succede, come si dovrebbe procedere, quando i modelli di cui disponiamo non solo offrono predizioni probabilistiche e non deterministiche, ma forse addirittura sono misspecificati – cioè incapaci di rappresentare con sufficiente fedeltà la realtà a cui si riferiscono?
A questa domanda cerca di rispondere lo studio Making Decisions Under Model Misspecification, pubblicato sulla rivista The Review of Economic Studies, di Simone Cerreia-Vioglio (Università Bocconi e IGIER) e Lars Peter Hansen (University of Chicago, Nobel per l’Economia 2013), Fabio Maccheroni e Massimo Marinacci (Università Bocconi e IGIER).
“Molti approcci alla teoria delle decisioni spesso trattano l’incertezza di modello assumendo che tra i modelli alternativi considerati ci sia quello vero che spiega la realtà,” spiega Cerreia-Vioglio, professore ordinario del Dipartimento di Scienze delle decisioni. “Ma nella pratica sappiamo che, molto probabilmente, nessuno dei modelli disponibili è il vero modello. Sono tutti approssimazioni. Il nostro lavoro prova a costruire un modo più rigoroso e prudente per decidere in questo contesto.”
Una cintura di sicurezza contro i modelli sbagliati
Lo studio propone un nuovo criterio di decisione che tiene conto non solo della varietà di modelli disponibili – come già fanno gli approcci “ambiguity averse” – ma anche della possibilità che tutti siano sbagliati in modo sistematico. Per farlo, distingue tra:
- modelli strutturati, cioè quelli su cui il decisore ha costruito delle ipotesi, basati su dati, teorie e assunzioni (per esempio: un modello climatico o un modello finanziario con parametri incerti);
- nodelli non strutturati, costruiti solo come “stress test” per valutare le conseguenze nel caso i modelli strutturati falliscano.
L’idea è introdurre una penalizzazione che aumenti al crescere della “distanza statistica” tra un modello plausibile e quelli più estremi, usati come forma di protezione contro errori di specificazione.
“Questi modelli non strutturati non sono credibili nel senso usuale: non li useremmo per prevedere il PIL o i tassi,” spiega Cerreia-Vioglio, “ma ci aiutano a capire quanto una decisione sia sensibile a errori nascosti nei modelli strutturati. In un certo senso, sono una cintura di sicurezza.”
Un esempio concreto: investire in un’economia incerta
Nel paper, gli autori presentano un esempio tratto dalla macroeconomia: un investitore deve scegliere un piano intertemporale di consumo e investimento, ma l’economia segue una tecnologia incerta, rappresentata da un parametro ignoto. I diversi valori di questo parametro corrispondono ai modelli strutturati. Il decisore, però, non si fida del fatto che il parametro vero sia davvero tra quelli considerati.
Applicando il criterio proposto, l’investitore valuta le opzioni possibili tenendo conto non solo del rendimento medio previsto dai modelli “noti”, ma anche della possibilità che questi siano mal tarati – e penalizza di più i piani che si rivelerebbero molto costosi se i modelli fossero sbagliati.
Un quadro teorico solido, con implicazioni pratiche
Alla base del lavoro c’è un apparato assiomatico rigoroso, che distingue tra due livelli di preferenze:
- una preferenza mentale, incompleta, che riflette i dubbi e le preferenze autentiche del decisore,
- una preferenza comportamentale, che è ciò che il decisore farebbe se fosse forzato a scegliere.
Questo doppio livello consente di modellare la paura che i modelli siano sbagliati, separandola dall’incertezza tra modelli alternativi. Il risultato è una nuova classe di criteri decisionali, che generalizzano quelli classici (come l’expected utility e il max-min Waldeano) e possono incorporare anche elementi di apprendimento bayesiano.
E ora?
Le applicazioni possibili vanno dalla politica climatica alla economia e la finanza. Ovunque si usano modelli – e si teme che siano sbagliati – questo approccio può offrire un supporto teorico per decidere meglio.
“Non possiamo evitare di usare i modelli che conosciamo,” conclude Cerreia-Vioglio. “Ma possiamo usare meglio l’incertezza che abbiamo intorno a loro. Il nostro obiettivo è dare strumenti per decidere in modo più consapevole, sapendo che la realtà sfugge sempre un po’ alla modellizzazione.”