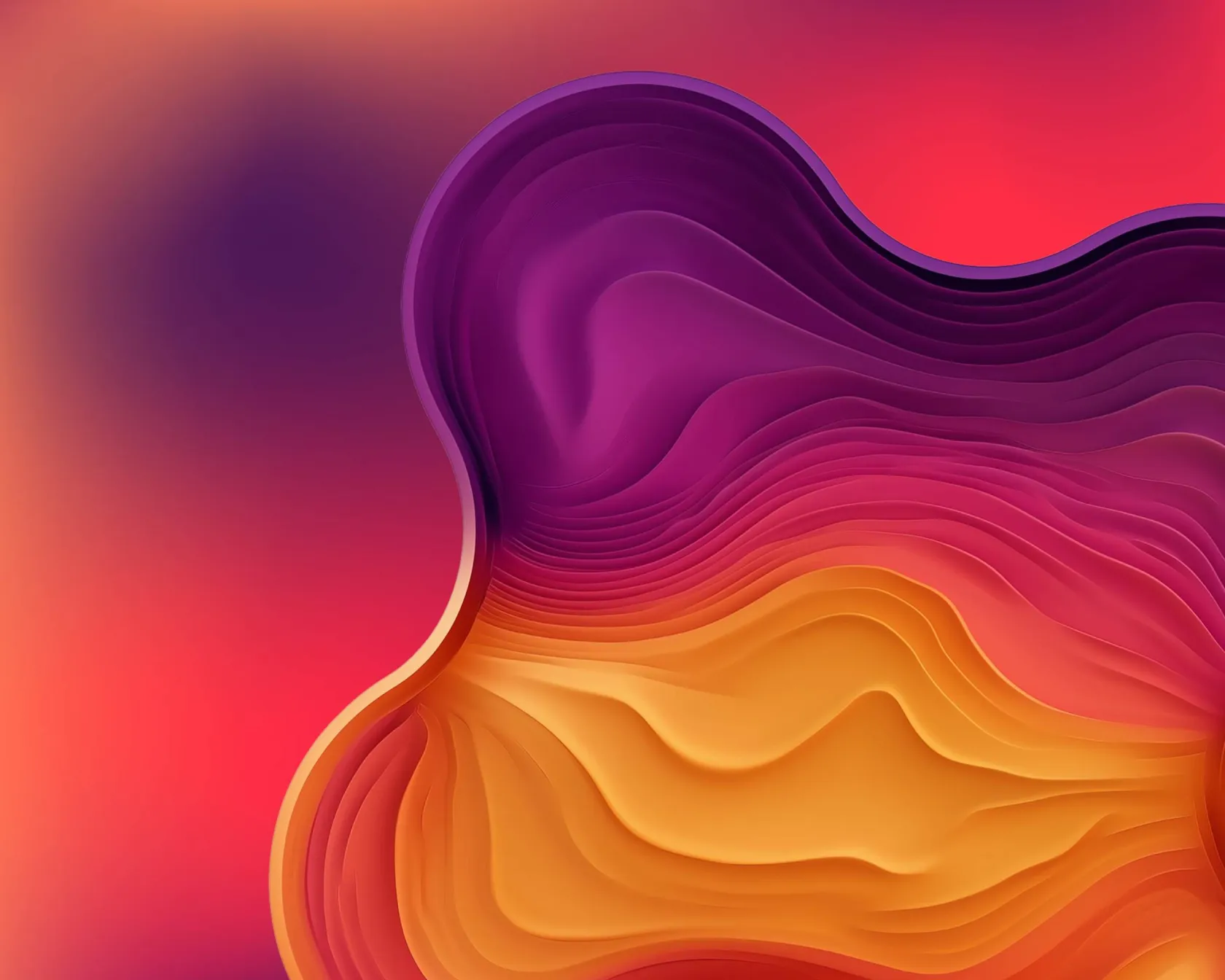Clima e regole: l’Europa frena
Il sistema bancario rappresenta un meccanismo di trasmissione fondamentale per la buona riuscita della lotta al cambiamento climatico nell’Unione Europea. Agli istituti di credito si richiede di misurare e rendere pubblici i finanziamenti verso i settori maggiormente responsabili della produzione di gas serra, come l’acciaio o la produzione di energia, consentendone gradualmente la riconversione verso tecnologie meno inquinanti. In questo modo le banche svolgono un ruolo di pubblico interesse e insieme, aiutando i propri debitori a pianificare per tempo la transizione ecologica, li mettono al riparo dal rischio di un brusco risveglio che porterebbe con sé fallimenti e perdite.
Dal 2022, con sempre maggiore insistenza, la BCE ha chiesto alle grandi istituzioni creditizie di misurare (o almeno stimare) l’impatto che i finanziamenti erogati esercitano sul riscaldamento globale, dotandosi di indicatori di rischio e monitorandoli in modo che il Consiglio di amministrazione possa favorire un progressivo spostamento verso investimenti più sostenibili. Dal 2023 l’Autorità Bancaria Europea ha introdotto un reporting obbligatorio con cui i maggiori istituti informano il pubblico sugli esiti di questi tentativi e sulle traiettorie previste fino al 2050 (quando dovrebbero essere completamente azzerate le emissioni nette di gas serra).
Affinché questo sforzo abbia esito positivo, è importante non lasciare sul sistema creditizio tutta la responsabilità della transizione, che deve essere innanzi tutto promossa dal settore pubblico. Pensiamo ad esempio ai mutui immobiliari: visto che gran parte dei gas serra è emessa dagli impianti di riscaldamento, sono necessari incentivi che consentano ai proprietari di apportare migliorie rivolte a risparmiare energia e a evitare l’uso di fonti particolarmente inquinanti.
Nell’ambito di questa collaborazione virtuosa tra pubblico e privato, l’Unione Europea ha introdotto due importanti provvedimenti: la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) e la CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive). La prima obbliga un numero crescente di aziende a rendicontare in modo dettagliato e trasparente i propri impatti ambientali, sociali e di governance; la seconda impone alle grandi aziende di identificare, prevenire e mitigare gli impatti negativi sui diritti umani e sull’ambiente dei propri fornitori e clienti. Con la progressiva entrata in vigore di queste norme, prevista nei prossimi anni, le banche avrebbero ricevuto un volume crescente di dati omogenei, standardizzati e tendenzialmente attendibili per conoscere l’effettivo contenuto di gas serra delle attività finanziate.
Lo scorso febbraio, tuttavia, la Commissione Europea ha chiesto a Parlamento e Consiglio di mettere in pausa questi provvedimenti per poterli sensibilmente edulcorare, riducendo di oltre l’80% il novero dei soggetti tenuti al reporting e in misura ancora maggiore il volume di dati richiesti. Questa brusca inversione di marcia, denominata “Pacchetto omnibus”, è stata giustificata con il mantra della competitività, anche alla luce dell’atteggiamento molto permissivo tenuto negli Usa dall’amministrazione Trump.
Si tratta di un’impostazione caricaturale e sventurata. Il primo requisito per essere competitivi è rimanere vivi e, se alle banche non verranno fornite le informazioni necessarie per conoscere e temperare i rischi climatici delle imprese a cui prestano denaro, sarà come costringerle a guidare nella nebbia su una strada ricca di insidie. Dire che le regole soffocano il mercato è come dire che l’acqua annega i pesci: quando nel 2023 Silicon Valley Bank saltò per aria perché i suoi rischi non venivano adeguatamente vigilati, ringraziammo il cielo che le banche europee fossero soggette a uno scrutinio più stringente. Neanche il tempo di lasciar asciugare l’inchiostro di quella storia, e di nuovo si vorrebbe far credere che le norme e la trasparenza siano solo un inutile impiccio.