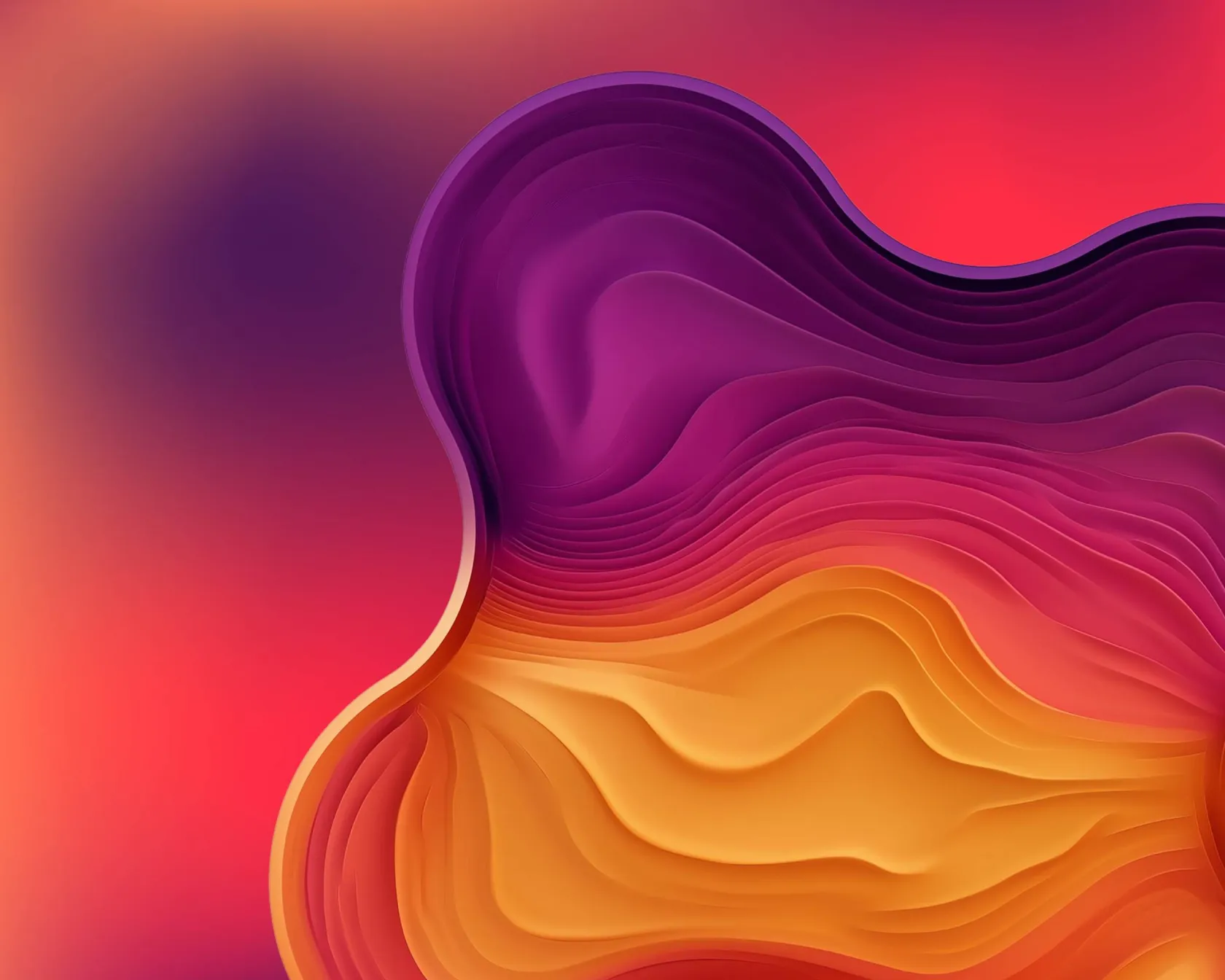Il meteo che muove i mercati
In un’epoca in cui la crisi climatica impone la sua agenda a governi e imprese, anche la finanza comincia a fare i conti con l’imprevedibilità meteorologica. Eventi climatici estremi - una volta eccezioni, oggi sempre più la norma - non impattano solo sulla vita quotidiana o sui bilanci delle compagnie assicurative, ma iniziano a influenzare anche i mercati finanziari. In particolare, il mercato dei future sul gas naturale statunitense, il NYMEX Henry Hub, mostra una sensibilità crescente alle previsioni meteorologiche, soprattutto quando queste annunciano ondate di freddo o caldo estreme.
È questo il tema al centro dello studio Can extreme weather forecasts lead to a risk premium? Evidence of a non-linear response in U.S. natural gas futures, firmato da Stefano Caselli, professore di finanza all’Università Bocconi e Dean della SDA Bocconi School of Management, insieme a Manou Monteux, Maria Cristina Arcuri e Gino Gandolfi, tutti accademici dell’Università di Parma e affiliati a SDA Bocconi .
Lo studio analizza oltre trent’anni di dati - dal 1990 al 2019 - combinando temperature osservate e previsioni a breve e medio termine (fino a due settimane), con i rendimenti giornalieri dei contratti future sul gas naturale. L’obiettivo è ambizioso: capire se e come le previsioni meteorologiche estreme possano generare un risk premium, ovvero un rendimento aggiuntivo legato al rischio che gli operatori assumono quando scommettono sull’andamento futuro dei prezzi.
Un premio per chi rischia con il meteo
“La nostra ricerca mostra chiaramente che non sono le temperature osservate a muovere i prezzi del gas, bensì le previsioni estreme rispetto alle medie stagionali”, afferma Caselli. “È la discrepanza tra ciò che ci si aspetta e ciò che si prevede, soprattutto quando si esce dagli schemi stagionali, a innescare reazioni nei mercati”.
L’analisi si fonda su un’architettura complessa che distingue tra temperature “realizzate” e temperature “previste”, normalizzando i dati rispetto alle medie climatologiche storiche. In termini operativi, gli autori hanno testato una strategia di spread trading, acquistando il contratto con scadenza più vicina (NG1) e vendendo quello con scadenza successiva (NG2), nei giorni in cui le previsioni indicano un clima insolitamente freddo (al di sotto del 10° percentile rispetto alla norma). In inverno, questa configurazione è associata a una maggiore domanda di gas per il riscaldamento, con un impatto diretto sui prezzi a breve termine.
I risultati sono sorprendenti: tale strategia avrebbe prodotto, in media, un rendimento composto annuo (CAGR) del 12% su un arco temporale di trent’anni, superando ampiamente il rendimento dello S&P500 nello stesso periodo (7,6%). Ma ancor più significativo è il rapporto rischio/rendimento: lo Sharpe ratio della strategia legata alle previsioni meteorologiche estreme è pari a 1,3 - circa il triplo di quello dell’indice azionario americano.
La metrica dell’estremo
Il paper evidenzia una dinamica interessante: all’aumentare dell’orizzonte temporale della previsione (da uno a due settimane) e al crescere della sua “estremità” (cioè quanto si discosta dalle medie stagionali), cresce anche il rendimento ottenibile da strategie basate su tali informazioni. Una relazione non lineare, che riflette l’incertezza intrinseca delle previsioni meteorologiche e la crescente rilevanza delle condizioni atmosferiche per i mercati energetici.
“Le previsioni a due settimane sono intrinsecamente più incerte, ma proprio per questo incorporano un premio maggiore”, spiega Caselli. “Chi scommette su un’ondata di gelo in arrivo si espone a un doppio rischio: quello meteorologico reale e quello legato all’accuratezza della previsione. Il mercato riconosce e remunera questo rischio”.
E se si pensa che tutto questo dipenda da un’efficienza imperfetta del mercato, il paper offre una risposta: le temperature osservate – in sé – non generano movimenti significativi nei prezzi. È solo quando le previsioni risultano errate rispetto alla realtà che i prezzi si aggiustano. Un comportamento “bayesiano”, come lo definiscono gli autori, che conferma l’efficienza del mercato nel processare le informazioni disponibili in anticipo.
Finanza e cambiamento climatico
Il lavoro si inserisce in un filone emergente della finanza climatica, che studia come i mercati reagiscano ai segnali legati al cambiamento climatico. Se le previsioni estreme sono sempre più frequenti, anche a causa dell’alterazione dei pattern atmosferici, è ragionevole attendersi che questi effetti si amplifichino.
“La nostra analisi mostra come il cambiamento climatico non sia solo una questione ambientale, ma stia ridefinendo i meccanismi di pricing nei mercati finanziari”, conclude Caselli. “Comprendere questi meccanismi è fondamentale per una corretta gestione del rischio, soprattutto per gli operatori del settore energetico”.