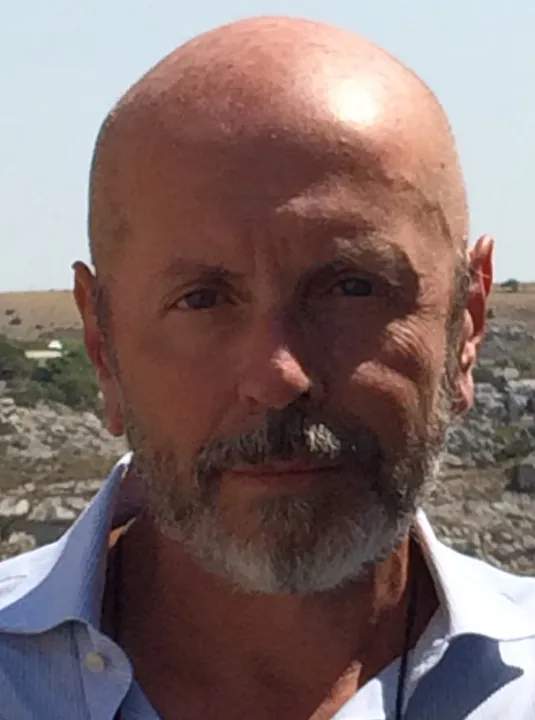Clima e banche centrali: perché la svolta verde dipende da politica e aspettative dei cittadini
Quando, nel 2015, l’allora governatore della Bank of England Mark Carney lanciava l’allarme sul “tragedy of the horizon” provocato dai cambiamenti climatici, il mondo delle banche centrali cominciava a muovere i primi passi verso il green. Ma a distanza di dieci anni, le risposte delle banche centrali ai rischi climatici restano fortemente divergenti: mentre BCE e Bank of England si sono spinte verso misure esplicitamente verdi, la Federal Reserve americana ha sempre fatto muro. “Non siamo noi i policymaker del cambiamento climatico”, ha ribadito più volte il presidente Jerome Powell.
Cos’è allora che determina se e quanto una banca centrale si impegna nelle politiche climatiche? A rispondere è il nuovo studio “The Green Central Banking Pendulum” firmato da Donato Masciandaro (Bocconi) e Manuela Moschella (Università di Bologna), che propone una lettura contemporaneamente economica e politica del fenomeno: l’attivismo verde delle banche centrali è il risultato dell’interazione dinamica fra preferenze politiche, sensibilità dei banchieri centrali e percezioni dei cittadini.
“Il green central banking non è una scelta burocratica neutrale. È un pendolo che oscilla in base alla direzione data da politici e opinione pubblica”, spiega Masciandaro, full professor e titolare della Intesa Sanpaolo Chair in Economics of Financial Regulation.
Il triangolo verde
La tesi centrale del paper è che l’attivismo ambientale delle banche centrali si innesca solo se esistono tre condizioni:
- Una spinta politica favorevole, ovvero il desiderio dei governi di segnalare attenzione al tema climatico usando la banca centrale come strumento di “cueing politico”.
- Una sensibilità ambientale del banchiere centrale, che può essere legata a convinzioni ideologiche o al desiderio di costruirsi una reputazione.
- Una società civile attenta, capace di percepire e valutare le azioni (o le omissioni) della banca centrale.
In questo schema, la banca centrale si muove come un agente in un rapporto di delega multilivello, dove deve contemperare la propria autonomia formale con le aspettative dei politici e le reazioni dei cittadini.
“Il nostro modello mostra che l’indipendenza legale della banca centrale conta meno di quanto si creda: ciò che conta davvero è quanto l’opinione pubblica ritiene legittimo l’intervento della banca centrale sul clima”, sottolinea Masciandaro.
I numeri dell’attivismo
Lo studio costruisce un modello teorico che integra politica monetaria, supervisione finanziaria e sensibilità climatica, quantificando l’effetto dell’attivismo verde in termini di inflazione e crescita. Il cuore del modello è una formula:
𝜒_ga = μΩ_pθ_cb,
dove:
- μ misura quanto i cittadini danno peso alle preferenze verdi dei politici;
- Ω_p rappresenta l’intensità dell’attitudine politica verde;
- θ_cb è la sensibilità del banchiere centrale al tema ambientale.
Il risultato è che, anche a parità di shock climatico, i risultati macroeconomici possono essere profondamente diversi a seconda dell’interazione tra questi tre fattori. Per esempio, un banchiere centrale “green neutral” in un contesto politico ostile e con cittadini disattenti produrrà effetti macro minimi, mentre un banchiere sensibile supportato da politica e opinione pubblica può avere un impatto significativo su leva finanziaria, inflazione e crescita. “Le banche centrali diventano attori verdi solo quando percepiscono che farlo conviene anche in termini di reputazione o consenso: non è un automatismo tecnico, ma un equilibrio politico”, afferma ancora Masciandaro.
La posta in gioco: l’inflazione climatica
Lo studio introduce anche il concetto di “climateflation” (inflazione da shock climatici) e “greenflation” (inflazione da transizione ecologica), sottolineando che le banche centrali non possono ignorare questi effetti nel medio periodo. Ma la risposta a questi fenomeni può essere più o meno incisiva a seconda della combinazione tra spinta politica e attenzione pubblica.
Fra i casi citati nel paper:
- la BCE, che ha integrato il rischio climatico nelle operazioni di acquisto titoli (“green QE”);
- l’uso degli strumenti macroprudenziali per indirizzare il credito verso settori a basso impatto ambientale;
- le differenze di approccio tra banche centrali “conservative” e quelle “populiste” nei confronti degli obiettivi multipli (inflazione, crescita, stabilità finanziaria, clima).
Una sfida aperta
Il paper non si limita a descrivere il presente, ma suggerisce piste di ricerca future: identificare eventi specifici che innescano il “salto verde” (nomine, pressioni della società civile, collaborazioni esterne) e studiare meglio le preferenze effettive di politici e cittadini sul ruolo green delle banche centrali. In definitiva, l’attivismo climatico delle banche centrali è tutt’altro che scontato. Come scrivono gli autori nelle conclusioni: “La green central banking non è un punto di partenza, ma una variabile endogena. Un equilibrio instabile e politico, che dipende da come si muove il pendolo delle aspettative.”