Perche' rivalutiamo l'incontro Rio+20
Gli esiti della Conferenza internazionale organizzata dalle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile "Rio+20" erano stati giudicati deludenti dalla maggior parte degli osservatori. Rispetto alla storica conferenza del 1992, in cui erano state poste le basi per un impegno globale per la salvaguardia del pianeta, venti anni dopo i 188 paesi partecipanti erano riusciti a partorire solo un documento di impegni generici e non vincolanti, The future we want.
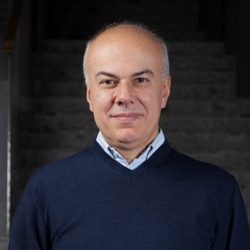 |
| Edoardo Croci |
A poco più di un anno di distanza quel giudizio va corretto. Rio+20, benché scarna di risultati tangibili immediati, ha portato alla condivisione di un'agenda globale per la crescita che vede gli attributi "green" e "low carbon" essenziali per il rilancio dell'economia, ha innescato un processo pervasivo di riforma della governance delle Nazioni Unite sul tema, ha portato all'elaborazione di nuovi obiettivi globali (Sustainable development goals) e ha promosso il coinvolgimento delle amministrazioni locali e delle imprese. Tra le eredità di Rio+20 ci sono più di 700 accordi volontari, per un impegno complessivo di 513 miliardi di dollari.
Il principale tema della Conferenza era proprio quello della green economy. Per rendere operativo questo concetto è emersa innanzitutto la necessità di definire metodologie e indicatori comuni per misurare lo sviluppo tenendo conto dell'impatto sulle risorse naturali e quindi l'opportunità di ridefinire le politiche pubbliche e le strategie di impresa valutando correttamente i costi e i benefici per l'ambiente. Tale sforzo ha generato una proliferazione di indici alternativi, tra i più recenti e promettenti dei quali figurano l'Iwi (Incluse wealth index), l'Hdi (Human development index), il Better life index e il World happiness index.
Un aspetto particolarmente rilevante per promuovere la green economy è quello di utilizzare correttamente gli strumenti di mercato, in modo che le esternalità siano internalizzate e i prezzi riflettano la scarsità delle risorse naturali, fornendo segnali efficaci ai produttori e ai consumatori. A questo proposito gli studi promossi dalle principali organizzazioni internazionali rivelano che tasse e sussidi non sono commisurati alle esternalità e in molti casi hanno addirittura un effetto distorsivo. Si pone così in evidenza la necessità di una riforma fiscale ecologica, che veda la fiscalità ambientale sostituirsi a quella sul lavoro e sul reddito nell'ambito di una riduzione complessiva della pressione fiscale per paesi come l'Italia. A ciò dovrebbe accompagnarsi una corretta incentivazione delle filiere green, come quelle delle rinnovabili e del riciclo, che hanno già dimensioni di tutto rispetto (stimate in circa 30 miliardi di euro per il nostro paese).
Nella Environmental performance review sull'Italia pubblicata quest'anno dall'Ocse si mette in evidenza come le tasse ambientali generino solo il 6% circa del gettito fiscale complessivo, con una tendenza calante, mentre la fiscalità sul lavoro sia in aumento. È stata da poco riproposta una delega al governo per la riforma fiscale ecologica, elaborata, ma poi decaduta, sotto il governo Monti.
Gli ambiti potenziali di applicazione sarebbero ampi, sia a livello di amministrazione centrale, che locale. Tra i settori interessati: l'energia, dove è aperto il dibattito sulla preferibilità tra emission trading e carbon tax, la mobilità e trasporti, con lo sviluppo di sistemi di road pricing, in ambito urbano ed extraurbano (anche sulla base della direttiva europea "Eurovignette"), l'uso del suolo, con il prossimo avvio di mercati dei diritti edificatori in alcuni comuni, l'uso delle risorse naturali, con la definizione di tariffe in grado di riflettere pienamente il valore delle prestazioni ecosistemiche.