Una teoria della libera volontà e della libertà politica
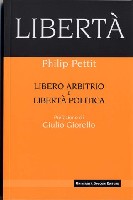 |
Philip Pettit |
In questo breve, ma denso volume (Libertà. Libero arbitrio e libertà politica, Università Bocconi editore, Milano, 2005, 194 pagine, 16 euro), Philip Pettit, filosofo e scienziato politico irlandese con cattedra a Princeton, presenta una teoria della libertà che ha l'ambizione di spiegarne sia l'aspetto psicologico, sia quello politico. Una teoria unitaria della libera volontà e della libertà politica.
Il cardine della teoria è la responsabilità. "Il fatto che di qualcuno si dica che è libero in entrambi gli ambiti normalmente significa che può essere ritenuto responsabile per quello che fa nell'esercizio di tale libertà", spiega subito Pettit.
Seguendo un percorso che va dall'aspetto psicologico a quello politico, Pettit nota che, quando descriviamo come libere le persone ci riferiamo a due cose: "non agiscono sotto pressione, costrizione, coercizione ecc. e sono idonee a essere ritenute responsabili rispetto a un ambiente che rende disponibile un numero elevato di opzioni ben distinte (...) Esiste un genere di interazione, e un genere di influenza, che soddisfa in modo paradigmatico i requisiti indicati. Si tratta dell'interazione che avviene quando le persone cercano di risolvere un comune problema discorsivo – di giungere a un'opinione condivisa – attraverso comuni mezzi discorsivi".
È per questo che la teoria della libertà di Pettit è una teoria della libertà come controllo discorsivo: "la libertà di un agente come persona si identificherà con il controllo che possiedono le persone nell'ambito delle relazioni favorevoli al discorso. Un agente sarà una persona libera nella misura in cui ha la capacità di discorrere e ha accesso al discorso consentito da tali relazioni". La nozione di controllo discorsivo ha una dimensione psicologica (la capacità di discorrere) e una sociale (le relazioni con gli altri).
Il passaggio all'aspetto politico è possibile perché esistono soggetti collettivi (discontinui rispetto agli individui che li costituiscono) che possono essere ritenuti responsabili del proprio agire e, a loro volta, ritenere altri responsabili del loro e anche a questi può essere applicata la teoria della libertà come controllo discorsivo.
Pettit definisce perciò un ideale di libertà politica, che fa corrispondere al non dominio. "Una persona gode del non dominio nella misura in cui non è esposta al potere di interferenza arbitraria di altri", indipendentemente dal fatto che tale potere venga esercitato o meno. "L'ideale di non dominio ci indirizza verso l'impresa strutturale di mettere a punto istituzioni che possano avere il potere coercitivo e altri poteri a questo connessi, ma così vincolate che tali poteri di solito non vengono esercitati arbitrariamente".
La filosofia politica centrata sull'ideale di non dominio, secondo Pettit, è quella repubblicana, una tradizione di pensiero "che sorge a Roma, sebbene attinga al lavoro di molti pensatori greci, viene rielaborata nelle città dell'Italia rinascimentale, riappare in Inghilterra al tempo della guerra civile e, modificata per conciliarsi con la monarchia costituzionale, attraversa il XVIII secolo. Nella sua incarnazione più drammatica, fornisce le idee cruciali che ispirarono le rivoluzioni americana e francese".
L'idea che il signore, pur non interferendo realmente, privi il soggetto della sua libertà fu, in seguito, considerata troppo radicale e la tradizione repubblicana venne "sostituita da un complesso di idee che furono descritte, con un termine coniato in quel periodo, liberali". Una di queste idee era la concezione della libertà non più come non dominio, ma come non interferenza. Ma "l'opportunità di una tale sostituzione – ovvero, che il vecchio ideale sarebbe troppo radicale per il popolo nel suo complesso – non risulta più valido. È giunto il momento di una rinascita repubblicana dell'ideale della libertà politica come non dominio".
Pettit conclude il suo lavoro tracciando alcune linee che possano condurre a una moderna filosofia politica repubblicana. "Lo stato repubblicano", scrive l'autore, "ha il compito di imporre tali restrizioni al potere privato affinché le persone, per quanto possibile, possano condurre la propria esistenza in condizioni tali che gli altri non abbiano un potere arbitrario su di loro". Ma lo stato stesso è un pericolo per la libertà dei cittadini e "l'unica soluzione è quella di rendere l'azione dello stato, per quanto possibile, non arbitraria. Uno stato sarà non arbitrario, in questo senso, nella misura in cui è costretto ad attenersi solo ed esclusivamente ai comuni interessi riconoscibili dei cittadini".
Tale riconoscibilità degli interessi comuni è garantita solo da una "prassi democratica elettorale e contestatoria". "La democrazia elettorale", infatti, "contribuisce in maniera significativa ad assicurare che i candidati più plausibili al ruolo di comuni interessi riconoscibili vengano presi in considerazione e, se convincenti, tendano a guadagnare sostegno. D'altra parte in queste democrazie deve anche esserci spazio per la contestazione perché solo questa possibilità garantisce contro la rappresentazione di interessi particolaristici in termini di questioni di comune interesse riconoscibile. Una tale "democrazia bidimensionale" è "l'unico stato immaginabile che può ambire a proteggere le persone dal dominio senza diventare a sua volta strumento di dominio".