L’Europa verde alla prova di Copenaghen
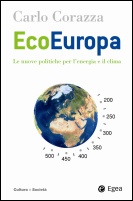 |
Carlo Corazza EcoEuropa Le nuove politiche per l'energia e il clima Egea, 2009, 256 pagine, 22 euro |
Nel 2006 il rapporto Stern è stato chiaro: in assenza di misure ulteriori di riduzione delle emissioni nell'atmosfera, i costi e i rischi del surriscaldamento del pianeta porteranno a una riduzione del pil globale del 5% l'anno, mentre evitare l'impatto del cambiamento costerebbe meno dell'1% del pil mondiale. Non c'è davvero tempo da perdere se è vero quanto ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite a settembre, di ritorno da un viaggio all'Artico: "Stiamo correndo verso l'abisso col piede pigiato sull'acceleratore". È partendo da queste evidenze che Carlo Corazza, in EcoEuropa – Le nuove politiche per l'energia e il clima (Egea, 2009, 256 pagine, 22 euro), racconta lo spirito con il quale il Vecchio continente sta affrontando la sfida, oggi in funzione degli obiettivi del "20-20-20" e del vertice di Copenaghen di dicembre 2009, domani in vista delle proposte di drastici tagli delle emissioni entro il 2050. La nuova politica è presentata come il superamento della tradizionale contrapposizione tra crescita e ambiente e indicata come via, non solo per lo sviluppo sostenibile, ma anche per far uscire dalla crisi un'Europa più forte e recuperare parte della sovranità energetica.
Corazza ricostruisce, con grande ricchezza di particolari e dati, il percorso complesso, spesso accidentato, delle istituzioni europee sia verso l'integrazione tra clima ed energia, tematiche che devono necessariamente essere affrontate in parallelo nella definizione delle policy, sia verso la ricerca "di una voce sola", forte, che risponda alle nuove sfide. Dall'analisi dei documenti e dei vertici internazionali emerge la convinzione che debba essere l'Europa, a livello mondiale, a ritagliarsi un ruolo di leader nel taglio delle emissioni inquinanti, riuscendo a trovare una posizione unitaria. Come indica Corazza, la strategia comune europea di lotta ai cambiamenti climatici e di sviluppo delle politiche energetiche passa da alcune tappe necessarie. Innanzitutto, la creazione di un effettivo processo di apertura e integrazione del mercato europeo dell'energia, la cui attuazione vede ancora forti resistenze da parte di alcuni stati membri dell'Unione, come la Francia. Il completamento del mercato europeo e delle relative infrastrutture di rete, che porterebbe a maggiore concorrenza e libertà di circolazione, aumentando la competitività e la sicurezza di approvvigionamento, "non è una deregulation come talvolta si è portati a pensare", scrive Corazza. Per l'Europa il mercato non è una giungla dove vale la legge del più forte per cui "liberalizzare significa anche 'regolare' e garantire il rispetto effettivo di tali regole. Serve un quadro normativo europeo non solo per aprire il mercato ma per far sì che questa apertura sia in linea con alcuni interessi generali o diffusi, a cominciare da quelli dei consumatori". E, in questo contesto, risultano di centrale importanza norme che decidano dell'unbundling, ossia l'obbligo di separazione delle reti di fornitura e di trasmissione da quelle di produzione, o l'azione della commissione per far rispettare le regole di concorrenza e evitare abusi di posizioni dominanti. Sul fronte della riduzione delle emissioni, Corazza dà conto, tra le altre misure, del percorso di riforma dell'emission trading system (ets), della "guerra dell'auto pulita" in Europa, dei progetti di cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica. Ma anche, in vista del vertice di Copenaghen, delle diverse posizioni dei grandi player e della lunga e complessa battaglia per stabilire, a livello globale, la fissazione dell'anno di riferimento, quello che deve fare da base per verificare l'abbattimento delle emissioni. La sfida più difficile dei prossimi summit, tuttavia, riguarderà "un gigantesco problema di equità", spiega l'autore. "La capacità di contenimento dei gas serra è stata finora 'occupata' dai paesi industrializzati. Ai paesi in via di sviluppo è stata lasciata una quota minima di possibilità di emissioni, superata la quale si rischiano disastri che avrebbero conseguenza innanzitutto proprio sui paesi più poveri". Altro capitolo fondamentale è quello sulle ultime strategie per il recupero di efficienza energetica e per il raggiungimento degli obiettivi di utilizzo delle fonti rinnovabili, non ancora centrati rispetto alle aspettative. "Secondo stime della Commissione", spiega Corazza, "se il target del 20% al 2020 fosse centrato, si otterrebbe una riduzione annuale di 900 milioni di tonnellate di co2. Il consumo di carburanti potrebbe essere ridotto a 300 milioni di tonnellate l'anno, con un risparmio dello 0,3% del pil europeo (circa 50 miliardi di euro)". E con investimenti tra i 13 e i 18 miliardi di euro l'anno, il prezzo delle fer "potrebbe scendere ulteriormente rispetto al calo già vistoso degli ultimi anni". Un dubbio rimane però sull'Italia: "Il nostro paese è pronto a mettere con decisione la barra verso le nuove opportunità, anche occupazionali, aperte nel mercato dalle green tecnologies?", si chiede Corazza. "O saremo trascinati, obtorto collo, magari a colpi di procedure d'infrazione, verso il rispetto della nostra fatidica quota del 17% entro il 2020 imposto dall'Europa?". Infine, il tema della sicurezza energetica che fa sempre più da sfondo alla stessa politica estera europea e spinge i 27 a liberarsi da possibili ricatti energetici presenti e futuri puntando su un nuovo sistema di reti e su nuove fonti domestiche, tra cui appunto, le rinnovabili, ma anche il nucleare. Carlo Corazza è direttore della rappresentanza a Milano della Commissione europea